L'esperienza di cura nelle situazioni estreme: un dialogo a tre voci e uno sguardo al codice deontologico
La riflessione sulla funzione dell’Assistente Sociale all’interno di un’equipe di Cure Palliative nasce da un’esigenza sentita da molti: cercare di chiarire e rafforzare la professionalità specifica e l’intervento di questo professionista in un ambito operativo in cui gli operatori sanitari principali come medici e infermieri spesso non valutando l’importanza del lavoro sociale, lo riducono ad un rapporto assistenzialistico fatto di pratiche burocratiche a favore dei malati. Questa visione limitativa ha origine, nella storia italiana in un vecchio dibattito non ancora, purtroppo, risolto tra Servizio Sociale e Sanità.
Sussiste ancora oggi all’interno dei Servizi Sanitari uno scarso riconoscimento dell’Assistente Sociale come professionista capace di mettere in atto un processo di aiuto sociale, così come recita il nostro Codice Deontologico: “egli è un professionista che si confronta con altri professionisti competenti”.
Anche la Bioetica ci insegna che è fondamentale tendere ad un lavoro di équipe multidisciplinare per salvaguardare la globalità della persona: purtroppo manca ancora una cultura, una conoscenza di quello che rappresenta per il gruppo e per la persona malata il contributo dell’Assistente Sociale che, per preparazione di base e “forma mentis” è potenzialmente un membro ideale di un’équipe di assistenza al malato in fase avanzata.
I principi deontologici di “non direttività”, di personalizzazione, di rispetto dei ritmi della persona nella sua centralità, in ogni intervento, sono fondati sul valore, sulla dignità, unicità e rispetto dei diritti universalmente riconosciuti, abilitano l’Assistente Sociale ad essere “coscienza critica”. Da qui l’importanza e la necessità di recuperare il contributo sociale all’interno del percorso di cura e sostegno alla persona malata in fase terminale.
Allargando l’osservazione a servizi non italiani, emerge, per esempio, che in Francia l’Assistente Sociale, sia trattato e ascoltato nella diversa competenza, al pari dei medici e degli infermieri e sia sollecitato per consulenze sociali approfondite all’interno della medicina palliativa, che si basa su un approccio globale della persona. Il suo ruolo può svilupparsi ed avere un ampio utilizzo anche laddove la cura sanitaria è principale; questo professionista nel suo essere e nel suo capire fà da ponte fra il paziente, la famiglia e gli amici per aiutarli a comprendersi e a comunicare.
Comunicando, in qualsiasi modo, la sua sofferenza il malato pone un interrogativo angoscioso e lacerante a chi lo assiste. Egli chiede se può sentirsi ancora una persona, se ha ancora la dignità di quello che era, se la sua vita è sempre degna di essere vissuta, se ha conservato, malgrado le trasformazioni fisiche, il suo valore e la sua umanità. Lo sguardo che il malato ha per se stesso, ma ancora di più lo sguardo che si posa su di lui e su chi incontra è determinante.
Il paziente non è una persona isolata, ma è membro di una famiglia e di un gruppo sociale che sono coinvolti in un delicato processo omeostatico. Occorre aiutare la famiglia e il malato ad affrontare la difficile situazione causata dalla malattia, concedendo il tempo necessario a tutti per riprendersi dallo smarrimento e con dolcezza, far comprendere meglio l’informazione ricevuta. Un atteggiamento di autentica accoglienza favorirà il necessario confronto con la realtà. L’atteggiamento dell’Assistente Sociale è quello di chi è chiamato a “saper leggere” il cuore e le inquietudini delle persone.
Sia il Codice Deontologico che la Bioetica raccomandano all’operatore, nell’espletamento dei propri compiti, di riconoscere sempre la realtà sociale del malato in quanto egli è la migliore guida per indicare il modo con cui vuole essere accompagnato. L’Assistente Sociale può diventare, se richiesto, un punto di riferimento stabile in una situazione altrimenti caotica e difficile da gestire. Tutto ciò avviene all’interno di un processo di aiuto che si articola in fasi che presuppongono un’apertura alle reti sociali attraverso:
- la richiesta di aiuto: decodifica e comprensione della domanda;
- analisi conoscitiva del caso;
- valutazione preliminare e operativa della situazione: identificare i bisogni reali, non sempre espressi;
- elaborazione del progetto di intervento e contratto con la famiglia;
- realizzazione degli interventi: supporto al malato e alla famiglia;
- valutazione dei risultati.
– Questo professionista fa in modo che le persone coinvolte possano esprimere la loro sofferenza nelle varie fasi dell’aggravamento della malattia, passaggio necessario per evitare un sovraccarico emozionale del malato e della famiglia, egli può aiutare le persone vicine al malato a riacquistare, nel limite del possibile, un certo senso di controllo e di autostima che va oltre il percepirsi come vittime di un fato crudele. È essenziale educare la famiglia a non considerare la persona morta socialmente prima ancora della sua morte fisica.
– Salvaguarda i diritti e i doveri della persona malata in quanto essere sociale in relazione alla sua inguaribilità e le permette di sistemare le sue pendenze e necessità (testamento, affari, indicazioni per il funerale, desiderio di vedere alcune persone, ecc.), poiché come dice un noto bioeticista “ curare dei morenti è anche aiutarli a conservare uno status sociale, cioè a rimanere inclusi nella loro famiglia, nel loro ambiente, nella città di cui sono membri e in modo più ampio, nella società del loro tempo, in un contesto che implica diritti e doveri”.
– Fa circolare le informazioni all’interno dell’équipe per poter programmare un intervento comune di cui tutte le figure professionali siano consapevoli e protagoniste attive. Il lavoro di équipe è fondamentale e al suo interno l’Assistente Sociale mette in gioco le sue capacità professionali di empatia e di ascolto con la comprensione delle dinamiche di gruppo. Offre in più la sua conoscenza delle risorse della comunità e del territorio, al fine di accompagnare la persona in tutta la sua globalità e ricchezza.
– Mantiene i rapporti con i familiari anche dopo il decesso del malato per non farli sentire abbandonati e per rilevare eventuali difficoltà che possano sorgere nella fase del lutto.
Pur non essendo ancora riconosciuto in Italia uno spazio preciso, fatte salve alcune realtà, per l’intervento sociale nell’assistenza dei malati terminali, sulla base dei principi deontologici della professione, della metodologia e della competenza l’Assistente Sociale può avere un ruolo importante all’interno dell’accompagnamento di queste persone nella fase finale della loro esistenza.
Credo che sia indispensabile adoperarsi insieme per un’apertura, un cambiamento di mentalità affinché le strutture, per far fronte al problema dell’accompagnamento alla morte, non rimangano testimonianze isolate, ma diventino luoghi comuni di vita.
Per concludere oserei dire, che, l’intervento dell’Assistente Sociale, avvalendosi del Codice Deontologico, strumento di orientamento della propria professione, può mirare a ridurre gli effetti sociali che il disagio a causa della malattia, ha provocato, e contribuire, insieme all’équipe, a migliorare la qualità della vita del paziente e di conseguenza della sua famiglia. Per fare ciò è essenziale identificare gli aspetti prioritari da affrontare, stabilire delle mete comuni, progettare un intervento che sia frutto della corresponsabilizzazione di tutte le persone coinvolte. È importante permettere la realizzazione di una impostazione d’équipe che stimoli ciascuno a fornire tutti i contributi possibili. Per il paziente, si tratta soprattutto di non mettersi in un’ottica di dipendenza, ma di riappropriarsi di una propria progettualità e potere decisionale. Anche se grave al malato, devono rimanere degli spazi di autonomia e responsabilità, perché possa sentirsi persona viva sotto tutti gli aspetti compreso quello sociale. L’unicità della persona umana umana, la sua irripetibilità ed individualità si realizzano non nella morte, evento uguagliante e assoluto ma, nel processo del morire. E questo processo non può essere affrontato nella solitudine, deve essere portato al centro delle relazioni del malato.
L’assistente Sociale che incontra il malato deve ricordarsi sempre che il tempo, in questo frangente, è prezioso e non può essere sciupato, perché il malato deve poter gestire il tempo che gli rimane. La morte è un evento della vita e deve essere vissuta come tale nella consapevolezza della propria fragilità e umanità.
Il “lavoro sociale”, credendo nei prerequisiti del bene della persona, così come dettato dalla Bioetica e dal nostro Codice Deontologico, riconosce sempre e in qualsiasi situazione il suo valore, la sua dignità, la sua unicità, anche quando arriva alla fine della vita, perché mai come in questo momento la persona ha bisogno di essere riconosciuta, rispettata ed amata come essere umano, degno tutt’ora di vivere pienamente anche gli ultimi istanti. Spero che questo mio dire possa essere utile a tutti noi che ci siamo “messi in cammino” per far sì che la morte torni ad essere un evento naturale della vita.
Enza GiganteUltimo aggiornamento
27 Agosto 2012, 19:22
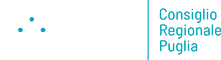 Croas Puglia
Croas Puglia